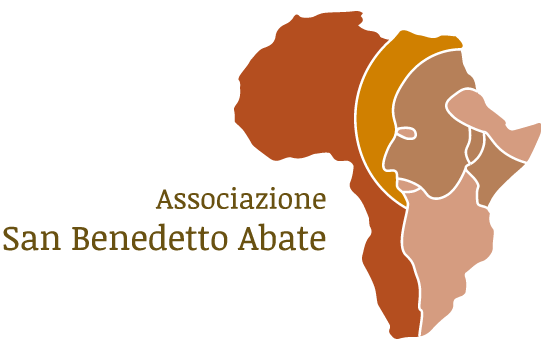Ancora una volta, nel nostro annuale viaggio in Africa, verso i bambini orfani di Sakété ed i villaggi di palafitte del fiume Ouemè, con i soliti compagni di viaggio, decidiamo di andare a Ouidah, per quello che abbiamo scelto di chiamare pellegrinaggio della memoria, che ci riporta indietro nel tempo a ricordare una delle pagine più tristi della storia della nostra umanità durata diversi secoli: la tratta degli schiavi.
Ancora una volta, nel nostro annuale viaggio in Africa, verso i bambini orfani di Sakété ed i villaggi di palafitte del fiume Ouemè, con i soliti compagni di viaggio, decidiamo di andare a Ouidah, per quello che abbiamo scelto di chiamare pellegrinaggio della memoria, che ci riporta indietro nel tempo a ricordare una delle pagine più tristi della storia della nostra umanità durata diversi secoli: la tratta degli schiavi.
Nonostante i nostri tanti impegni che abbiamo preventivamente programmato in Italia, con la consapevolezza, frutto dell’esperienza di questi anni, che in Africa i programmi sono relativi alle strade piene di buche, all’autovettura, messa sempre a dura prova e che ti può lasciare dove meno te lo aspetti, ad un grosso camion che perde una ruota e si ribalta lasciando la strada bloccata per chissà quanto, ad una improvvisa rivolta degli operai mal pagati e molto altro, eccoci di nuovo qui dinanzi, ad monumento patrimonio dell’ UNESCO chiamato “Porta del non ritorno“.

Questo luogo, al di là dei pochi venditori di oggetti di artigianato, che a differenza degli altri posti non ti assalgono, ma ti invitano con molta discrezione a visitare il loro piccolo negozio, è custodito da un sacrale silenzio. Anche l’Oceano Atlantico, di solito sempre pronto a mostrare l’immensità della sua energia, sembra quasi trattenere l’inconfondibile rumore delle sue potenti onde, dinanzi a questa Porta, posta su un meraviglioso tratto di costa, dove per diversi secoli milioni di schiavi venivano venduti per un niente: una bottiglia di whiscky valeva 4 uomini; una pipa, due. Per un cannone era assai diverso, valeva ben 14 uomini o in alternativa 21 donne; queste, come ben sappiamo, per pura e semplice idiozia maschilista, fin quasi ai nostri giorni, valevano meno degli uomini. Dinanzi alla Porta del non ritorno, anche noi udiamo questo silenzio assordante che non riesce a coprire quelle scene disumane di uomini che senza alcuna pietà vendevano altri uomini. Per qualche istante, ciò che abbiamo letto nei libri scritti dai tanti ricercatori e studiosi è come se prendesse vita. A dare inizio alla triste storia c’erano i “G quattro” a governare il mondo. Le grandi potenze europee erano Spagna, Portogallo, Inghilterra e Paesi Bassi. Crearono immensi insediamenti in America su vasta scala. Come al solito è il denaro a muovere gli interessi delle potenze economiche di ieri e di oggi. Gran parte dei proventi erano legati alla creazione di piantagioni di canna da zucchero, caffè e cacao; soprattutto con la penetrazione portoghese in Brasile, con la prospettiva di ricavare dalle colonie anche risorse minerarie. Si richiedeva, quindi, l’uso di grandi quantità di manodopera per il lavoro pesante, perché gli indigeni americani, a causa della loro minuta statura, non erano adatti. Gli schiavi africani dal punto di vista fisico non avevano problemi a sopportare il lavoro forzato, perciò i portoghesi e gli spagnoli furono abilissimi a fare i calcoli: molte braccia forti, molte colonie, piantagioni, miniere. Senza pensarci più di tanto diedero inizio al più grande commercio di schiavi della storia: quello attraverso l’Oceano Atlantico, che assunse rapidamente proporzioni senza precedenti, dando origine nelle Americhe a vere e proprie “economie basate sullo schiavismo”, dai Caraibi fino agli Stati Uniti meridionali.
Non riuscendo a trattenere sentimenti di profonda indignazione, ci muoviamo verso la Place Chacha, dove c’è un grande albero. Il tronco centrale di notevoli dimensioni, avvolto da una stoffa rossa verso l’alto, dal quale si biforcano altri due grandi tronchi che all’inizio sono avvolti da una stoffa blu. A vederlo da lontano fa impressione perché l’effetto che produce è quello di un uomo appeso a testa in giù. Credo che l’effetto ottico sia voluto, l’umanità qui è stata brutalmente calpestata, capovolta!

Quest’albero è un altro silenzioso testimone che ha visto radunarsi in questa grande piazza uomini e donne in catene che venivano portati da altri uomini all’acquirente bianco, direttamente delegati dai diversi re del regno di Dahomey, antico nome del Benin. Dietro il grande albero di ficus l’ingresso di un museo ove vengono gelosamente custoditi i segni tangibili di questa inumana violenza, verso coloro che avevano l’unica sventura di nascere poveri. Questa storia è quasi impossibile da poter raccontare, ma è assai più difficile da poter digerire per chi vive qui e per tutti gli africani. È così anche per colui che ci fa da guida al museo della memoria, sorto sulle rovine di un’antico forte portoghese perché a vendere uomini, donne e bambini – dopo aver aiutato nella razzia – erano “i nostri stessi fratelli”, emissari di re che avevano quattromila mogli. Immagino che l’attività quotidiana di queste donne fosse quella di pregare perché il re non morisse. Ad annunciare la sua morte erano due grossi vasi tondi sfiorati da un pezzo di stoffa che emanavano un suono cupo, profondo, lento. Era il suono che preannunciava anche la loro triste fine! Morto il re le mogli dovevano essere sepolte attorno alla sua tomba, in fosse comuni ovviamente, con l’unica gloria di essere state le mogli del re.
L’atroce rito
I riti sappiamo essere una serie di atti e gesti codificati attraverso delle norme o semplici consuetudini. Gli antropologi ci dicono che i comportamenti stereotipati dei riti offrono rassicuranti modelli da seguire, costruendo quella che viene in seguito definita come “tradizione”.
L’atroce rito che rendeva schiavi faceva passare uomini e donne in catene dal grande
albero di ficus ad un altro albero, un grande baobab, dove le donne dovevano girare in circolo per sette volte e gli uomini per nove. Tale gesto rituale – attorno all’albero della dimenticanza – doveva servire appunto a far “dimenticare” agli schiavi chi erano stati, la loro vita precedente doveva essere “appesa” al baobab. Tutto ciò, ovviamente, era finalizzato ad evitare la ribellione. Dopo il “girotondo” attorno all’albero della dimenticanza, uomini e donne venivano stipati in un grande stanzone senza finestre, dunque senza luce. Lì sarebbero rimasti per tre mesi. Era il tempo che di solito serviva per la traversata e tale tortura serviva a stabilire chi avrebbe resistito, cioè a fare una prima selezione. Chi moriva e si ammalava veniva gettato in una fossa comune. Chi restava veniva fatto girare per tre volte attorno sempre al solito baobab. Significava che una volta morto – in quella lontana terra che non poteva neanche immaginare, il suo spirito sarebbe tornato. Una sorta di omaggio alla propria tradizione che, venditori e venduti condividevano e che doveva scongiurare l’ira degli antenati.


Tutti questi riti erano finalizzati alla partenza. Gli schiavi venivano incatenati a coppie, piede sinistro dell’uno e piede destro dell’altro. Una lunga fila di uomini, alla quale seguiva quella delle donne, con i loro bambini donati gratis, veniva portata sulla spiaggia e fatta salire con battelli alle navi, ferme in rada. Stipati con grande attenzione per occupare tutto lo spazio possibile, gli uomini stesi a testa in giù, per evitare qualsiasi forma di ribellione, le donne stese con il viso rivolto verso l’alto perché così era più facile abusarne sessualmente. Le anfore romane e greche venivano stivate con molta più attenzione, cura e con lo spazio necessario, perché portavano derrate alimentari, che evidentemente valevano molto piú di uomini e donne. Molti preferivano gettarsi in mare durante il tragitto fino alle navi, scegliendo di morire pur di non affrontare un futuro sconosciuto e che faceva paura. Le stime degli studiosi su quanti siano stati i deportati variano da un minimo di dodici milioni ad un massimo di venti. In effetti è davvero difficile stabilire quanti siano morti durante le traversate, che duravano all’inizio molti mesi.
Potenti e poveri di ieri e di oggi
Davvero inconcepibile che tutto ciò potesse aver l’avallo del Papa Niccolò V, che nella bolla Romanus Pontifex riconosce al sovrano portoghese anche la schiavitù dei neri d’Africa, sottomessi ai colonizzatori portoghesi o in seguito all’occupazione o in virtù di acquisti commerciali. Nonostante il suo predecessore, il papa Eugenio IV, emise una bolla contro la schiavitù, la Sicut Dudum, che fu però disattesa dagli spagnoli. Niccolò V scriveva nella bolla citata:
«Perciò noi […] poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere nostre tra le altre cose, piena e completa facoltà al re Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i Saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo, ovunque essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene, mobile ed immobile, che sia di loro proprietà, e di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tali regni». Ci vorranno diversi decenni ed un altro Papa perché si cambiasse totalmente pensiero al riguardo. Il 2 giugno del 1537 papa Paolo III, nella sua bolla “Veritas Ipsa”, detta anche “Sublimis Deus”, indirizzata al cardinale Juan Pardo de Tavera, arcivescovo di Toledo, dichiarava che gli Amerindi « veros homines esse» (“gli indios sono uomini veri”) e scomunicava tutti coloro che avessero ridotto in schiavitù gli indios o li avessero spogliati dei loro beni. Riconoscendo dunque in pieno quanto San Tommaso d’Aquino aveva scritto molti secoli prima nella Somma teologica, dimostrava come la schiavitù fosse in contrapposizione con la legge naturale concludendo che: «…per sua natura un uomo non è destinato a usare un altro uomo come un fine. Non vi è nessun motivo che si riferisca alla natura per ammettere la sottomissione di un uomo al potere di un altro uomo riducendolo in schiavitù, poiché la giusta ragione è il fondamento morale dell’autorità e non la coercizione. L’autorità giusta è quella che viene esercitata per il bene dei sudditi, quella imposta agli schiavi è invece ingiusta perché mirata solo al conseguimento del proprio utile».
Ovviamente sia la dottrina che il magistero dei papi, dai diversi re spagnoli e portoghesi furono totalmente disattesi.
Oggi è il sistema capitalistico a produrre i nuovi schiavi, quelli che vengono stipati nelle carrette del mare che spesso colano a picco, trascinando uomini donne e bambini, ed il mediterraneo diventa la loro tomba. Oltre 3mila migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo dall’inizio del 2017 mentre tentavano di raggiungere l’Europa via mare, secondo le cifre riferite dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). La media dal primo gennaio del 2017 (al 26 novembre) è di quasi 10 morti al giorno. Nella nota diramata a fine anno scorso si sottolinea che è il quarto anno consecutivo in cui la soglia dei decessi è stata superata. Ricordiamoci che anche noi in Calabria abbiamo la nostra tendopoli baraccopoli di migranti che a San Ferdinando ed in altre parti della Calabria vengono sfruttati da caporali senza scrupoli. Davvero questa triste storia sembra non avere mai fine.

Porta del ritorno